Ero in macchina che pioveva quando ho ascoltato “Windowpane” dall’ultimo Tinsley Ellis. E quando ascolti un blues come questo, in un giorno di pioggia, non puoi che rimanerne folgorato, colpito da rimandi acustici emotivamente potenti, assieme ad un falsetto che evoca Skip James e tutta l’inquietudine e tristezza di quel che chiamerebbero Bentonia – style. Ma non è la sola, questa seconda traccia, a squarciare il velo di una “nuda verità”: due sole parole per tradurre semplicemente il senso di un disco che, come fu per il Clapton di “From The Cradle”, per il guitar – hero di Atlanta è a suo modo un ritorno alle origini. Diversamente da quello splendido “Slowhand” però, Ellis non reinterpreta i blues della sua formazione, ma in chiave scarna ed essenziale, come i pochi brani scelti in proposito (Son House; Leo Kottke; Muddy Waters) una manciata di autografi costruiti in uno stile “a togliere”, scevro d’orpelli elettrici che pur si addicono al suo blues (potente, “acceso” e full band per almeno una volta in ciascuno degli States, si racconta) che lo ha contraddistinto in una carriera di più di quarant’anni.
Stavolta e per la prima volta invece, Tinsley Ellis soddisfa un’esigenza che pure risponde a chi lo ascolta e lo segue, nei concerti dove spesso rivela questo lato, quello acustico, che nemmeno si può scindere dall’elettrico in ogni musicista che si dica completo, come ci insegnano i più vari ascolti che da Rory Gallagher al su citato Clapton, mai si fecero mancare. Sicché quest’album, in presa diretta, coglie un momento magico per il musicista di casa Alligator, “fotografato” non solo in senso figurato (vedasi la copertina, esplicita a riguardo) con una sporca dozzina di folk-blues in un ventaglio chitarristico aperto, non solo alle accordature, ma anche a un piccolo bagaglio da “hobo” con ritagli dell’Anthology Of America Folk Music in tasca. Non fosse che per l’impeccabile “Death Letter” di Son House, dove Ellis pare un altro, posseduto persino nella voce; ma anche nel cavallo di battaglia che per una vita ha suonato dal vivo, la “The Sailor’s Grave On The Prairie” di Leo Kottke, appunto. Intorno a questa, altre splendide strumentali come “Silver Mountain”, “Alcovy Breakdown” o “Easter Song”, a richiamare i fantasmi di John Fahey, tra inizio e fine disco. Neppure mai sopiti gli spiriti del Delta, che “Tallahassee Blues” o “Horseshoes And Hand Grenades” rivitalizzano più che mai, con “Hoochie Mama” a raccontarci come un blues possa ritornare acustico anche nello stile di Chicago. Grande blues, per Ellis, maturato prima sulla strada che su disco: come un buon whiskey, prima nella botte e poi in bottiglia.
Matteo Fratti

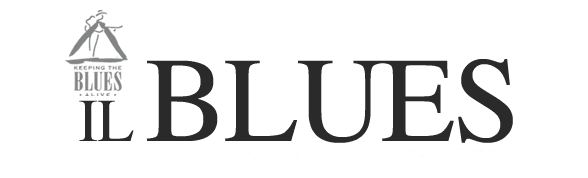









Comments are closed