Qualche cenno del “decennale”
«Lo avevamo sempre atteso. Che prendesse forma un Festival che si curasse più della qualità dei suoi interpreti che dei nomi da proporre al pubblico. (…..) e che la Direzione artistica sia affidata a chi avesse come obiettivo la presenza di artisti scelti liberamente e non quelli imposti dalle, purtroppo inevitabili, ragioni di cassetta.»
Le righe sopra, le abbiamo estratte dalla prima recensione del suddetto Festival, apparsa nel n.92 del settembre 2005. Aspettative come “qualità” e “presenza di artisti scelti liberamente”, sono state nel corso del tempo non solo un dato di fatto, ma dei valori fondanti. Con l’edizione di quest’anno è stato celebrato il decennale della Associazione Rootsway, nata per mano di un manipolo di appassionati di musica che proprio nel 2004 avviò il cammino con un concerto del duo Fabio Treves/Alex Gariazzo, alla Casa della Musica a Parma. Nel corso degli anni, qualche, purtroppo, immancabile problema e fisiologici avvicendamenti al loro interno, non hanno comunque scalfito quella che è, prima ancora della figura di organizzatori, la passione per la musica da condividere con gli altri, musica blues ovviamente, con tutti i suoi stati d’animo. Già dalla seconda edizione, i “ragazzi” del Rootsway avevano le idee chiare e, prima di chiunque altro, hanno creato un Festival itinerante, complice i bellissimi luoghi situati lungo o a ridosso del fiume Po ed inseriti in una terra che trasuda cultura, anche culinaria, creando con bluesmen neroamericani (gran parte dei quali provenienti direttamente dagli Stati Uniti del Sud) e bianchi, una atmosfera tipica del Mississippi che dalle sue colline scende nella pianura del Delta. Ed ecco quindi che anche qui da noi il blues va a bagnarsi nelle acque del grande fiume, e assume una dimensione elettrica che nonostante non possa estrinsecarsi in qualche juke joint, ha trovato una sua dimensione unendosi con l’opportunità di stare “a tavola col blues!” La formula è stata azzeccata. Sono stati coinvolti bluesman che altrimenti non avremmo mai visto in Italia, come Willie King, T-Model Ford, Robet Belfour, L.C. Ulmer, Louis Youngblood, Big George Brock, Robert Bilbo Walker, Kenny Brown, North Mississippi Allstars, Eric Deaton, Watermelon Slim e tanti altri, non tralasciando una nutrita presenza italiana e una rappresentanza europea, e senza dimenticare le varie iniziative collaterali: convention internazionale sul mondo del blues, incontri con esperti della materia, presentazione di libri, mostre fotografiche. Per il costante impegno, coerenza e qualità, il “Roots & Blues Food Festival” è stato insignito nel 2009 a Memphis del prestigioso “Keeping The Blues Alive Award” nella categoria “Blues Festival”, proprio nello stesso anno che la nostra Rivista “Il Blues” ricevesse lo stesse riconoscimento nella categoria “Print Media”.
27–28 giugno 2014, il Festival
Iniziamo col dire che la presenza di pubblico ha superato ogni aspettativa in entrambe le serate, con soddisfazione di tutto l’entourage del Roostway e del Podere “La Bertazza” di Diolo di Soragna, ubicato nel bel mezzo della campagna ed unica sede fissa da otto anni del Festival. La prima sera è stata aperta dal duo parmense/reggiano dei Dead Horse Bones che si dividono gli strumenti a corda amplificati, chitarre, mandolino, violino, si accompagnano con basi campionate e senza troppi convenevoli hanno l’audacia di strapazzare le dodici battute del blues, aggiornandole con ruvide sonorità punk e con i passaggi che rimandano a certe cose di Nick Cave. Non si preoccupano di accattivarsi il pubblico con standard di blues, è tutta farina del loro sacco, è tutto ruvido, deformato, ipnotico, diretto, è la forma blues che si evolve e che ci rimanda a certe produzioni Fat Possum. Di sicuro ai puristi più di una perplessità rimane, ma i Dead Horse Bones sono un emblema del blues da qui in avanti.
Con il Marco Pandolfi Trio, Marco voce/armonica/chitarra, Federico Patarnello batteria e Lucio Villani contrabbasso, si cambia registro. Saltiamo i convenevoli perché il suo percorso artistico è noto a tutti. Il leader ha basato il concerto proponendo pezzi dall’ottimo ultimo CD “No Dog In This Hunt”, ma, ci sembra doveroso, vogliamo sottolineare che sul palco erano in tre, e a questa edizione del Rootsway hanno dato l’ennesima prova di coesione, di senso della misura nella proposizione di accattivanti blues lenti o toccati dal ritmo, con un feeling ora intenso, ora pacato. Abbiamo verificato anche dal vivo che l’equilibrio fra passato e presente vive di personalità, su tutti “Three Shots In A Row” e “Rosario”, passando da “Ain’t That Lovin’ You Baby” e “Last Night”.
Per l’altro trio che ha chiuso la serata, non c’è miglior introduzione che riportare le parole di uno spettatore, il quale avvicinatosi allo stand dell’organizzazione appena iniziato il loro concerto, ha chiesto se fossero americani. Gli è stato risposto che sono italiani, di Livorno! Questo per dire il travolgente impatto che i Tres (Roberto Luti chitarra, Simone Luti basso e Rolando Cappanera batteria), hanno avuto sul pubblico, un impatto che non ha perso consistenza per tutto il loro concerto interamente strumentale, perché nessuno canta, ma ci credete se diciamo che almeno per una volta, non abbiamo sentito la mancanza della voce, carpiti come eravamo da impressionanti, corrosive, variegate, ma controllate dinamiche rock. Roberto è un mago nell’estrarre dalla sua chitarra scrostata fraseggi taglienti di rock e blues e momenti di vero pathos abbassando i toni, allorché introduce la dilatata e sublime “504th Stone Into The Sea” e rende omaggio a Fred McDowell con una emozionante “Keep Your Lamp Trimmed And Burning”, dichiarando alla fine del pezzo che «tutti i musicisti passati o meno dal Rootsway Festival devono pagare pegno all’immenso bluesman!». Roberto è decisamente uno dei migliori chitarristi al mondo, perché prima della tecnica, c’è la sensibilità e l’umiltà. Poi c’è Simone, un altro che merita elogi, con il basso a cinque corde crea dinamiche pazzesche, un incrocio armonioso di funky, potenza e melodia, ed infine Rolando che batte sui tamburi della sua batteria con tenacia senza mai perdere controllo e lucidità. Il pubblico spintosi sotto il palco, non dimenticherà di aver assistito ad uno dei migliori concerti da quando esiste il “Rootsway”, alla faccia delle case discografiche ansiose solo di trovare del talento fra quelli che si esibiscono davanti a delle telecamere, perché i due dischi, uno in studio e l’altro dal vivo, i Tres se li sono autoprodotti! Col senno di poi, ci siamo accorti che è stato per il “Rootsway” l’anno dei trio.
Infatti la seconda serata è stata aperta da tre giovanissimi musicisti, Ste Barigazzi (chitarra e voce), Giorgio Pinna (armonica), Enrico Zanni (batteria), uniti sotto il nome di Poor Boys. Giovani ma già con un’attitudine alla tipologia di blues che proviene dalle Hills del Mississippi, per farlo poi incontrare con il blues della città. ma avendo Kimbrough e Burnside quali punti di partenza. Si applicano con dedizione non c’è dubbio, pullulano di idee ma sulla lunga distanza si perdono un po’. Comunque per il momento va bene così, vista l’età. Li aspettiamo con interesse. Aspettavamo con interesse anche Roberto Menabò, magari con la chitarra in una mano e il suo ultimo libro “Vite Affogate Nel Blues”, nell’altra. E’ arrivato solo con il libro, per una breve presentazione, che purtroppo non tutti hanno seguito perché realizzata nel momento di maggior affluenza ai tavoli per cenare. Peccato.
L’ultima scossa al “Rootsway” è arrivata dai Bagamojo, di Paul “Paolino” Venturi e del bassista Max Sbaragli, accompagnati come nel loro CD da Dudù Kouatè alle calebasse, n’goni e percussioni varie e da Stephanie Ghizzoni, canto, rullante, washboard. Paolino è stato il primo bluesman in Italia a ripercorrere in senso inverso la strada dal Mississippi al Mali; dopo aver catturato l’attenzione con una sensibile proposta di blues acustico, ha approfondito le radici neroamericane arrivando nel Mali, ed è salito più a nord verso il Marocco, per cogliere un altro aspetto non avulso dal blues, la musica gnawa di derivazione berbera. Per vari impegni personali, non capita spesso di vedere al completo il “progetto Bagamojo”. Il loro spettacolo è stato ottimo, in quanto ancora una volta si è sentita la miglior commistione di blues neroamericano con suoni maliani, garantita dai fraseggi di chitarra di Paul Venturi e da Dudù Kouatè, evidenziata da Max Sbaragli al basso e vivacizzata dalla poliedrica Stephanie Ghizzoni, la quale ha alzato l’asticella dell’intensità cantando una preghiera voodoo haitiana che è dedicata al dio dei venti. Rilevanti sono stati anche i pezzi estratti dal loro CD, come “Fair Man Blues”, God Moves On The Water”, “Hard Time Killing Floor” e “Tenebris”. Nel mezzo Paolino ha eseguito una sua composizione, “Going To Essauira” (la famosa città marocchina, che fu anche dimora di Jimi Hendrix), liberamente tratta da un pezzo di Ali Farka Toure.
A chiudere il “Rootsway” un altro ritorno dopo il 2006, da Clarksdale, Mississippi, Super Chikan, con le sue irresistibili chitarre autocostruite. Per l’occasione è stato accompagnato dal sorprendente giovane batterista dei Poor Boys, Enrico Zanni e dal bassista Max Sbaragli. Man mano che il concerto si inoltrava nella notte, Super Chikan (all’anagrafe James Johnson) si faceva sempre più coinvolgere dagli apprezzamenti del pubblico, proponendo uno via l’altro standard del blues come “Baby What You Want Me To Do”, “Crosscut Saw”, “Born In Mississippi”, un omaggio allo zio Big Jack Johnson e a John Lee Hooker unendo insieme, “Big Boy Now” e “Boom Boom”, “Baby Scratch My Back”, “Hey Bo Diddley”, inserendo qua e là nel canto il suo “marchio”: il verso del gallo. E poi via ad una interminabile jam con i musicisti che lo hanno preceduto, più Andrea Cocco all’armonica. Sì, è stato proprio un bel decennale!
Silvano Brambilla

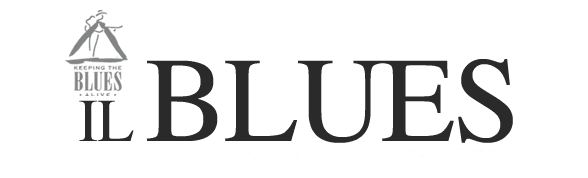















Comments are closed