Nel nome del padre
di Matteo Bossi
Non è sempre facile per artisti di seconda (o terza!) generazione seguire le orme dei propri antenati e allo stesso tempo trovare un modo per essere completamente sé stessi. Anche per Ronnie Baker Brooks, forse, è stato così. Lui che ha cominciato sul finire degli anni Novanta come indipendente e si è fatto conoscere suonando ovunque, guadagnandosi il rispetto sia degli artisti della generazione precedente sia della comunità di appassionati di blues. Il suo nuovo album, “Blues In My DNA”, in uscita ora, è il primo per Alligator, un’etichetta che occupa un posto speciale per la sua famiglia, essendo stata casa per tutti i dischi di suo padre, il compianto Lonnie Brooks, per tantissimi anni. “È così,” conferma lui, “e diversi membri dello staff li ricordo da quando hanno iniziato! Siamo cresciuti insieme, per così dire. Ho lavorato con loro per i dischi di papà ed ora con il mio. E questo è molto bello. Conosco Bruce probabilmente da quando avevo dieci anni e ricordo di quando chiamava a casa e ci diceva di accendere la radio e cercare una stazione che quasi non prendevamo -accendi, trasmettono una canzone di tuo papà proprio ora! -Ed era così orgoglioso e lo eravamo anche noi di sentire papà alla radio. Manda avanti veloce di anni e ora Bruce mi manda email sull’incidere un disco!”
In fondo era una cosa che doveva accadere, tu su Alligator?
Quando ho deciso di firmare con Bruce…per prima cosa devo dare credito al mio manager, John Boncimino, ha reso tutto più facile. Avevo la mia etichetta, ce l’ho ancora, Watchdog Records, non pensavo di farlo, ma lui mi ha detto, “pensiamoci su, c’è molta storia qua”. Durante la pandemia ho avuto molto tempo per pensare ed effettivamente aveva senso. Ha organizzato dei meeting con Bruce Iglauer e dopo un paio di incontri, la cosa ha iniziato ad acquistare ancora maggior senso. Ho ripensato agli inizi della mia carriera, il primo disco su cui ho suonato è stato “Bayou Lightning Strikes”, il disco dal vivo registrato al Blues Etcetera qui a Chicago. Il primo disco su cui ho cantato è stato ancora su Alligator, “Like Father, Like Son”, (su “Satisfaction Guranteed”)…un sacco di prime volte. Quando abbiamo deciso di farlo ho detto, “la copertina dev’essere simile a quella di papà, usero la stessa chitarra che usava lui sul suo primo album Alligator, di fronte al lago a Chicago. Come tributo per mio padre”. La chitarra con cui ha posato per “Bayou Lightning” è la prima che ha comprato. È stato davvero come tornare a casa.
Forse questo senso di famiglia si deve anche al fatto che alcuni tuoi amici e colleghi sono incidono a loro volta per Alligator, pensiamo a Shemekia Copeland, Toronzo Cannon o Coco Montoya, sei anche ospite sul suo ultimo disco…persone più o meno della tua generazione che stanno portando avanti la torcia, perché tuo padre e i suoi amici vi hanno preparato la strada, per citare una tua canzone.
È molto vero. Shemekia l’ho vista crescere, siamo come fratello e sorella, è come un membro della famiglia. Coco Montoya è un fratello, abbiamo anche in progetto di andare in tour insieme per supportare il suo disco e il mio…Toronzo lo conosco da prima che fosse un artista solista, quando suonava in giro per Chicago. Anche Tommy Castro è un fratello o Nick Moss un altro soldato del blues a Chicago. Perciò sì, è come tornare a casa e spero di portare a tavola qualcosa che possa ispirare qualcun altro.
E hai lavorato con Jim Gaines.
Sì, lo ha suggerito Bruce ed ho detto di sì, la cosa aveva senso. Avevamo lavorato insieme per “Roadhouse Rules” di mio padre e mi piace Jim Gaines, il suo modo di lavorare, molto rilassato, senza pressione, in un’atmosfera molto creativa. Come un senso di libertà di creare…se funziona, bene usiamolo, altrimenti andiamo avanti. Ha un buon orecchio per questo e senza dubbio alcuno sa come ottenere un bel suono di chitarra. E dopo le registrazioni, potevi startene lì ad ascoltare le sue storie su alcuni dei musicisti leggendari con cui ha lavorato…è semplicemente di ispirazione. E sono stato onorato di lavorare con lui.
Ha anche lavorato con molti amici di tuo padre, come Albert Collins.
Sì e ha lavorato con Stevie Ray Vaughan, Luther Allison, Steve Miller, Huey Lewis & The News…qualcuno di questi artisti non sapevo avesse lavorato con lui, perché io sono in campo blues. Ma c’è una influenza blues in tutto quello che ha registrato, puoi sentirla, anche nelle cose che ha fatto con Santana, ci sono le radici. Mi è piaciuto lavorare con lui, è un pozzo di conoscenza.
Qual è stato il processo di scrittura per questo disco? Nei tuoi lavori c’è sempre stato molto materiale originale.
Papà ha sempre spronato me e mio fratello a scrivere canzoni…ha cominciato a farlo da piccoli. Non scorderò mai quando ci disse, -chi scriverà la prossima Sweet Home Chicago o la prossima Got My Mojo Working? Abbiamo queste canzoni, ma la vostra generazione deve portare qualcosa di suo a tavola. E per farlo dovete scrivere canzoni che raccontino la vostra storia. – Non ho mai pensato di cantare, e d’altra parte non riuscirei ad essere autentico, di raccogliere cotone o lavorare nei campi…lo capisco, ma non starei facendo nulla di personale in questo caso. Cerco di portare qualcosa di fresco in quel che faccio, in ogni disco cerco di fare qualcosa che connetta i puntini tra la vecchia generazione quella più giovane. È sempre stato il mio obiettivo, fin dal primo giorno. Non posso farlo come mio padre, Buddy Guy o Albert Collins…la loro scuola mi ha dato la fiducia per provare a fare le mie cose. E mi piace molto scrivere, come nasce un’idea e vederla diventare una canzone. Poi suoni la canzone e vedi la reazione della gente, è un altro livello di apprezzamento della scrittura. Mi piace proprio il processo di scrittura. Ho presentato all’Alligator una trentina di canzoni, tutte originali…perché avevo in cantiere altri dischi che non sono stati pubblicati.
Durante la pandemia hai lavorato ad un album con Big Head Todd?
Sì! Abbiamo inciso un intero album acustico. Volevamo farlo uscire, ma il mio manager ha detto, “no, meglio aspettare”. Stavamo venendo fuori dalla pandemia e stavamo parlando con Alligator. Così ci siamo detti, pubblichiamo prima il disco elettrico, ma quello acustico uscirà un giorno, è davvero buono. Durante la pandemia ci sono stati momenti di timore, la paura dell’ignoto, e la musica mi ha davvero aiutato a superarli. Tenevo un live su Facebook ogni venerdì e provavo cose differenti durante lo show, questo mi ha indotto a scrivere altre canzoni.
Siete buoni amici con Todd.
Si io e Todd siamo come fratelli. Mi ha aiutato molto. Abbiamo avuto bisogno l’uno dell’altro in momenti cruciali delle nostre carriere. Quando ci siamo conosciuti suonavo con mio padre. Abbiamo aperto per lui a Chicago all’Aragon Ballroom. Era la notte di Halloween. All’epoca stavo cercando di realizzare il mio primo album solista, ma non riuscivo ad ottenere un contratto discografico. Tutti questi grandi erano ancora vivi e nessuno offriva un contratto a un giovane come me. Avevo delle canzoni pronte e ne stavamo parlando, “beh, ma non serve una casa discografica, puoi farlo da te”, disse lui. “Cosa?” replicai. Nessuno della mia generazione in ambito blues pensava di fare qualcosa del genere. Era il 1996/97. Ho iniziato la mia etichetta nel 1998. È stato lui l’ispirazione per la Watchdog. Ed è stata la chiusura di un cerchio quando è tornato a vivere a Chicago per un po’ e ci siamo ritrovati, iniziando a scrivere canzoni insieme. E poi mi ha detto, “amico, perché non vieni in tour con noi?” Così sono andato in tour con loro e abbiamo scritto altre canzoni. Abbiamo finito per fare un disco e altri tour. Oltre al disco acustico che non è ancora uscito. Perciò si è un fratello, mi rende migliore.
Quest’album con Gaines lo hai inciso in Tennessee.
Sì, Jim ha un home studio, ha convertito la casa di famiglia di sua moglie in uno studio. È a circa due ore da Memphis e un’altra ora da Muscle Shoals, proprio nel mezzo. C’è un’atmosfera rilassata, non c’è molto, nessuna distrazione…ma puoi fare buona musica! Mi è piaciuto lavorare lì. Sono rimasto a casa sua, abbiamo guardato il football insieme, parlato, è stato bello. E molti dei musicisti che ha usato li conoscevo già per averci lavorato su dischi precedenti, e loro conoscevano me, c’era questa familiarità…perciò ci siamo detti, andiamo in studio e facciamo musica.
Questo è il primo disco su cui non suona tuo padre, purtroppo, ma in un certo senso è presente, con la sua benedizione, che hai deciso di inserire.
L’idea era proprio questa. Per tutti i miei dischi precedenti papà era ancora vivo. Mi dicevo, devo trovare un modo di inserire papà nel disco, essendo il mio primo su Alligator. Tutto questo non sarebbe successo se non fosse stato per lui. Grazie a lui ho conosciuto Bruce. Così quando abbiamo finito “Blues In My DNA”, mi è venuta l’idea di prendere l’intro di “Make These Blues Survive”, dal mio CD “Golddigger”, inserendola prima della canzone “Blues In My DNA”.
Anche il disco precedente, “Times Have Changed”, uscito sette anni fa, lo hai inciso in Tennessee, a Memphis però, con la produzione di Steve Jordan. E molti grandi ospiti, da Bobby Bland o Steve Cropper. Sono passati sette anni da tra i due dischi, c’è una ragione particolare?
Appena prima che registrassimo “Times Have Changed” mio papà si è ammalato e sono rimasto a casa a lungo per prendermi cura di lui, volevo esserci. Poi è mancato e poco dopo è morta anche la mia sorella maggiore. Era una cantante gospel. L’avevo aiutata un po’ per il suo disco, non ci ho suonato, ma le ho dato una mano a metterlo insieme. Ha inciso infatti un disco gospel poco prima di lasciarci. Poi si è ammalata mia mamma…perciò stavo attraversando tutto questo. È stato un periodo di dieci anni che ha messo a dura prova la mia famiglia. Poi è arrivato il momento di fare un disco ed ho iniziato a raccogliere idee, anche quando me ne stavo seduto a guardare una partita…cerco sempre di farmi venire delle idee e scrivere canzoni. O ripensare ad altre che avevo scritto anni fa. Ci è semplicemente voluto del tempo. Avevo la mia etichetta ma non il supporto finanziario.
L’hai costruita da zero.
Si, dalle fondamenta! E ci è voluto tempo. Ed anche la parte creativa richiede tempo. Quando ho iniziato la Watchdog eravamo io, mia madre, mia sorella e mio padre. E loro tre non ci sono più. C’è un vuoto che non sarà mai colmato e non è una questione di business, è la mia famiglia. E sto ancora cercando di adattarmi a questa perdita, capire che questo fa parte della vita, cerco di trovare un modo di superarla, sono le persone che amo, la mia essenza. E torno sempre alla musica. È sempre stata un elemento benefico, di guarigione, qualcosa che mi porta altrove con la mente, anche quando i miei erano vivi. Quando mi succede qualcosa, la musica mi aiuta ad affrontarla.
In ogni caso “Times Have Changed” è stato un bel momento?
Oh, sì, suonare con Steve Jordan è stata una fortuna. Come fare un master, lui è una enciclopedia vivente e di grande talento. E prima di tutto una brava persona. Ha solide radici in famiglia, sa come connettere le cose in musica, dal jazz al blues, dal funk al rock…conosce le ricette, come farle funzionare. E tutti nel mondo della musica conoscono Steve Jordan, perciò quando chiama rispondono al telefono. E così è successo a noi col disco. Ho imparato moltissimo da Steve, come fare un disco, come scrivere meglio, cantare e suonare meglio…ha accresciuto la fiducia in me stesso. Quando ho finito questo disco gli ho detto, “amico, tutto quello che sto facendo viene dalla fiducia e delle esperienze formative che tu hai reso possibili per me, grazie”. È stato un onore lavorare con lui e tutte quelle star, voglio dire, praticamente tutti tranne me avevano suonato su qualche hit! Quel che faccio io è tornare sempre a mio padre. Sono in studio con Bobby Bland, amico, un momento surreale! Arriva in studio ed io sono lì che penso, “Oh mio Dio, Bobby!” Gli abbiamo dato un microfono e lui comincia a parlare di come è diventato un cantante, di come lui e mio papà fossero amici…e ha detto, so che sai cantare perché tuo padre sa farlo, perciò andiamo a fare questa canzone. Iniziamo e mi viene in mente che ascoltavo quest’uomo da una radio a transistor sotto il cuscino quando ero un bambino…mi dicevo, sta davvero succedendo? È stato un disco speciale. All’inizio ero intimidito però, come lo ero da piccolo a suonare di fronte a papà a casa.
Per i dischi precedenti avevi lavorato con Jellybean Johnson, anche lui ha lavorato con grossi nomi, Prince su tutti.
Avere fatto quell’esperienza mi ha permesso di acquisire la fiducia per fare il disco con Steve (Jordan) e ospiti come Steve Cropper, Angie Stone, Al Kapone, Felix Cavaliere, Lee Roy Parnell…mi reputo fortunato.
A tua volta hai lavorato come produttore, ricordo in special modo “West Side Strut” di Eddy Clearwater.
Sì, ho prodotto un disco dei Juke Joint, dall’Olanda, uno di Eric “Guitar” Davis qui a Chicago che è scomparso, Chris Beard e uno di mio padre. In realtà ho iniziato il suo disco ma poi quando c’è stato l’interesse di Tom Hambridge io ho fatto un passo indietro. Ma ho dato una mano a mettere insieme il disco per papà, le canzoni, gli arrangiamenti…Quello con Eddy è nato dopo che lui è venuto ospite su un mio disco, “The Torch”
…avevi anche Willie Kent, Jimmy Johnson e tuo padre, su quel disco.
Si! Eravamo in studio ed ho cercato di pagare tutti loro, ma non hanno accettato un soldo da me. Non mi hanno lasciato pagare nemmeno il parcheggio! Ho detto, “grazie, ragazzi”. E loro, no ti vediamo, ti stimiamo, tu continua a fare quello che stai facendo…al che Eddy ha detto, “sai una cosa che potresti fare per me, Ronnie? Puoi produrre una canzone del mio nuovo album”. “Certo, ne sarei onorato”, gli ho detto. Così ho radunato la mia attrezzatura da registrazione e l’ho portata a casa sua, fuori Chicago. Abbiamo iniziato a lavorare su una canzone, “Hypnotized”, quella è stata la prima. Abbiamo finito quella e ci siamo detti che suonava davvero bene! Facciamone un’altra. E abbiamo continuato a farne altre. E poi passo le serate lì a casa sua e Eddy mi dice, “Ronnie, devi fare tutto il disco”. Abbiamo scritto altro materiale ed è stata una grande sensazione. Quei ricordi mi rimarranno sempre…il processo creativo è bellissimo per me. Non avevo mai fatto nulla a quel livello, eccetto con mio padre. E quando mio papà è mancato ero molto giù, depresso, Eddy mi ha chiamato dicendo, “volevo sapere come stai, so che probabilmente stai ancora in lutto per la sua perdita, ma voglio dirti che devi tornare al lavoro”. Voleva che gli producessi un altro disco. Io ero incerto, “non so, amico”, gli ho detto…ma mia moglie mi ha detto, “perché non vai lì e vedi come vanno le cose”. Ci siamo incontrati a casa sua e mi ha fatto sentire quel che aveva e abbiamo ricominciato…e questo mi ha aiutato ad affrontare il dolore. Per questo dico che la musica è terapeutica. Era qualcosa cui guardare per il futuro. Abbiamo preparato sei canzoni e poi se ne è andato anche Eddy. Nell’album acustico realizzato durante la pandemia ho inciso una canzone di Eddy come tributo. Si intitola “I Love You”, ed è molto bella. Anzi volevo che la facesse in acustico per il suo disco.
Sappiamo che da adolescente ti eri dedicato al basket e poi hai suonato il basso? E tuo fratello Wayne la batteria? Alla fine entrambi siete diventati chitarristi.
Eh si, abbiamo spezzato il cuore a papà! (ride). Voleva una band con noi. Una cosa non la dimenticherò mai. Avevo lasciato la band di papà per iniziare la mia carriera, Wayne anche ma suonava anche con lui. Ci siamo trovati tutti e abbiamo fatto un Brooks Family Tour. Eravamo diretti da qualche parte e sono andato sul retro del tourbus per vedere come stava papà, lui guardava fuori dal finestrino. “Non volevo disturbarti”, “no, no vieni qua”. Ci siamo seduti a parlare. Mi ha detto, “sai, il mio sogno era avere te al basso e Wayne alla batteria e andare in tour tutti insieme, come stiamo facendo ora, ma entrambi siete diventati chitarristi. Ti voglio dire una cosa: continua a sognare. Perché talvolta un sogno non si avvera proprio nel modo che volevi, ma si avvera. E sono così felice di avere voi ragazzi qui”. È stato un bel momento per me e la mia famiglia. Fare questa cosa con lui. Ha iniziato ad insegnarmi quando avevo sei anni. La prima volta che sono salito con sul palco con papà ne avevo nove. Era il gennaio 1976, era appena tornato dall’Europa. Quando chiamava casa per sapere come stavamo, una volta gli dissi, “papà voglio suonare con te quando torni”. E lui, “beh, tu impara due canzoni per quando torno e potrai suonare con me”. “Davvero?” Così ho imparato due canzoni e quando è ritornato hanno un organizzato una festa di bentornato al Pepper’s Hangout qui a Chicago. Mi ha chiamato sul palco ed ho suonato “Messin’ With The Kid” di Junior Wells e “Reconsider Baby” di Lowell Fulson. Al tempo non c’erano altri della mia età che suonavano blues. Molti miei amici giocavano a basket. Così ho smesso con la musica e ho giocato anche io. E ho spezzato il cuore a mio padre. Ma la cosa bella è che lui finiva di lavorare il venerdì, faceva un pisolino, si svegliava e andava a suonare il suo concerto la sera. Ma al sabato mattina si svegliava e mi accompagnava alla mia partita di basket. Si sedeva e mi guardava giocare, mi portava a pranzo, tornavamo a casa e poi andava a fare il suo concerto del sabato sera. Mi ha sempre sostenuto. Ma voleva davvero che suonassi.
Ma c’è sempre stato per te.
Non lo dimenticherò mai. Qualche anno dopo, mi ha portato con sé ad un suo concerto con Luther Allison, qui a Chicago al Soldier Field. Con Luther suonava suo figlio Bernard. Mi sono messo lì a guardarli e mio papà ha colto il mio sguardo, “vedi, figlio mio, se avessi continuato a suonare, potresti esserci tu a suonare con me ora, come loro”. Non avevo mai visto nessuno della mia età suonare il blues…Bernard è un anno e mezzo più vecchio di me. Bernard e Luther quando sono scesi dal palco mi hanno detto, “amico, abbiamo sentito che giochi a basket, ma di Michael Jordan ne abbiamo abbastanza, ci servono più B.B. King”. Da allora, io e Bernard siamo diventati buoni amici e lo siamo ancora. Mi hanno ispirato a riprendere a suonare. Papà mi ha lasciato suonare il basso, sono stato il suo roadie per un po’ e alla fine mi ha lasciato suonare la chitarra e sono entrato a far parte della band.
Hai ricordi legati di Dion Payton, suonava per tuo padre negli anni Ottanta. Era davvero bravo ed oggi è forse un po’ dimenticato.
Oh s’, Dion era un grande chitarrista! Ho imparato da lui ed ero anche il suo roadie, dato che era nella band di papà. Andavo in tour con loro nei weekend, portavo le chitarre, le accordavo, settavo gli ampli…e lui mi mostrava alcune cose alla chitarra. Mi ha influenzato molto, Dion suonava in modo davvero melodico e mi ha insegnato un sacco di cose, non solo tecniche, ma nel sentire le canzoni. O che un assolo dovrebbe avere un inizio, un punto mediano e una fine. È stato molto importante per me e sono contento che tu lo abbia menzionato. Oltretutto abbiamo in comune anche il nome, il mio secondo nome è Dion. Poi sono accadute molte cose, mi dispiace che non abbia avuto il riconoscimento che avrebbe meritato, era un artista incredibile.
Qualche anno fa, Keb’ Mo’ mi disse che stavate lavorando ad un tuo disco insieme. Lo finirete un giorno?
Si avevamo già scritto e registrato i due terzi del disco. Spero che quel materiale verrà pubblicato un giorno. Ne sono orgoglioso e adoro Keb’ Mo’, è come mio fratello maggiore. Mi ha insegnato in un certo senso come scrivere canzoni…ha aumentato la fiducia nella mia scrittura. Anche mio padre è un grande autore. Vivevo a casa con Lonnie e c’era come un soffitto, non posso arrivarci pensavo, e quando dai un’occhiata lì sopra vedi Albert Collins o Keb’ Mo’ che ti dicono, “dai, vieni su”.
Quando hai capito che tuo padre era Lonnie Brooks, non solo papà?
Quando sono salito sul palco a nove anni eravamo in un piccolo club, con tanta gente, ne ero intimidito. Poi ho visto papà fare “Sweet Home Chicago” al Navy Pier a Chicago, al blues fest, c’erano Muddy Waters, Koko Taylor, Son Seals, Willie Dixon, Mighty Joe Young, tutti questi grandi…e lui ci portò al concerto. Avrò avuto undici o dodici anni ed ero sul lato del palco a guardarlo. Ed è allora che mi sono reso conto, “woa, quello è papà!?”…c’erano migliaia di persone, non come in un club. È lo stesso che gioca a wrestling con noi a casa, perché lui ci faceva sempre divertire, giocando a carte, monopoli, qualsiasi cosa…e poi siccome era appassionato di arti marziali ci faceva vedere delle mosse! Guardavo quest’uomo con la chitarra che suonava di fronte a tutta quella gente ed era incredibile. Non scorderò mai quando è sceso dal palco e gli ho detto, “papà, è stata una cosa incredibile! Non potrei mai farlo”. E lui mi ha messo le mani sulle spalle e ha detto, “figliolo, certo che lo puoi fare, e anche meglio se continui ad esercitarti”. In quel momento ho capito che mio padre era diverso, non era come gli altri papà.
E qualche anno dopo eri su un palco con lui e alcuni di quegli artisti come Koko Taylor o Elvin Bishop per i tour Alligator.
Quella è stata una grande esperienza. Era il tour per il ventennale dell’Alligator. Anche solo essere lì attorno e vederli suonare ogni sera…Lil’Ed’, Katie Webster, Elvin Bishop, Koko Taylor…Ogni sera era lì in una stanza con Elvin Bishop che mi mostrava dei lick di chitarra country, blues o R&B…ed ho una registrazione dove siamo solo io e lui jamming e lui che mi mostrava dei passaggi alla chitarra. Ecco un’altra ragione per cui, guardando al passato, ha senso aver fatto disco con Alligator.
Pensi che ora sia più difficile portare avanti la torcia, visto che molti della generazione precedente non ci sono più?
È una buona domanda perché sto ancora cercando di trovare una rotta. Sono stato fortunato ad aver visto molti di loro all’apice e in un momento in cui la scena qui a Chicago era davvero vibrante. Tutta la comunità blues lo era. Molti grandi musicisti, maestri, secondo la mia opinione, come Otis Rush, Junior Wells, Magic Slim, Mighty Joe Young, Jimmy Dawkins…ho potuto frequentarli, scambiare idee con loro, suonarci insieme. Nessuno può rimpiazzarli. Nessuno. Quel che posso fare è condividere la mia esperienza con altri che vogliono entrare in connessione con la musica e apprenderla…posso provare ad essere un anello della catena, un ponte, che tiene insieme le cose e consente alla musica di continuare. Se mi guardo indietro mi sento fortunato ma c’è anche un vuoto. Non ho mai pensato di poter fare quello che facevano loro…anche se mio padre diceva, “sì, puoi farlo”. Penso fosse un dovere di tenere in vita il blues, portare la torcia…ma ora penso sia un onore. E se la pensi così ti toglie tutta la pressione.
Può essere schiacciante altrimenti.
Molto. Ho questi grandi in testa che continuano ad ispirarmi…ma non puoi essere alla loro altezza! Come dicevo, c’è un vuoto, perché queste persone mi erano molto care, come membri della famiglia, in molti casi. E fa male. Ma la nuova generazione, i ragazzi e le ragazze che stanno venendo su ora sono molto bravi. Fa parte dell’evoluzione della musica, dobbiamo guardare avanti. Cerco di essere un ponte tra il vecchio e il nuovo…è tutto quel che posso fare!

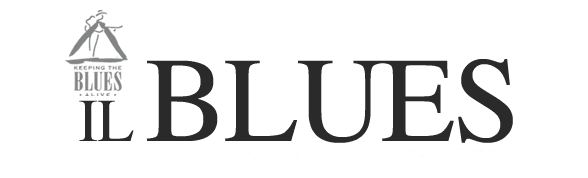













Comments are closed