L’edizione numero ventiquattro del festival elvetico si colloca nel solco delle precedenti, con qualche ritorno, qualche novità e un programma che si propone di trovare un equilibrio tra la varietà stilistica e la comune matrice blues. Il tutto facendo sentire i musicisti al centro della manifestazione, per accoglienza e professionalità, tanto è vero che chiunque vi abbia suonato vi ritorna molto volentieri.
Curtis Salgado ad esempio, lo avevamo già apprezzato nel 2008 e quest’anno tocca a lui inaugurare la scena del Casino, col fedele Alan Hager, versatile chitarrista co-intestatario del recente “Rough Cut” per l’Alligator. I due funzionano altrettanto bene dal vivo, tra le rivisitazioni “downhome” di alcuni classici e canzoni scritte da Curtis, il quale è sempre in possesso di una voce potente ed espressiva. Tra le prime ricordiamo, “Depot Blues” (Son House), “Too Young To Die” (Sonny Boy Williamson II), “Last Night” e una “You Got To Move” che guarda ad Elmore James, il gospel “Morning Train”. Tra le sue “I Will Not Surrender” e “One Night Only”. Curtis è anche ottimo armonicista, il che non guasta di certo e il dialogo con Hager è fitto e continuo, in qualche pezzo sono raggiunti dal batterista Casey Anderson che ben corrobora il suono. Un buon inizio non c’è che dire.
Poi ecco un nome nuovo, quello della cantante Annie Mack, originaria della zona di Minneapolis e titolare di un disco, qualche anno fa, “Baptized In The Blues” e di un EP più recente, “Tell It Like It Is”. E’ arrivata relativamente tardi alla musica e al blues, ma si è fatta conoscere a livello locale e partecipando anche agli IBC di Memphis nel 2012 e 2014. E’ accompagnata dal suo gruppo, un buon quartetto e attinge appunto ai suoi brani, con una forte componente autobiografica, “Baptized In The Blues” e “Call On Jesus”, con qualche occasionale cover, “Good Morning Little School Girl”. L’esordio è di buon impatto, la Mack ha voglia di farsi conoscere e una certa presenza, poi il resto del concerto, tra blues e rhythm and blues scorre piacevole, pur senza particolari picchi.
Altra atmosfera con i James Hunter Six, del chitarrista e cantante inglese di Colchester (l’accento quando parla è caratteristico), ora residente a Brighton e con una rinnovata composizione del suo sestetto. Sin da quando a fine Ottanta suonava sotto il nome Howlin’ Wilf, Hunter si è caratterizzato per l’adesione al soul e al rhythm & blues degli anni Cinquanta e Sessanta, ben prima che diventassero di moda suoni vintage e retro. Grande compattezza nei suoni, amalgamato dai fiati e da arrangiamenti molto validi. Hunter, autore dalla vena spesso sardonica, ha attinto molto dai recenti dischi su Daptone, cose come “Chicken Switch” o “Whatever It Takes”, ma anche la soffice “People Gonna Talk” dall’omonimo e fortunato album oppure una rara cover come la “Baby Don’t You Do It”, dei Five Royales. Un bel concerto da cui ricordiamo anche una riuscita “Minnute By Minute”, modellata dalla sua voce duttile.
Chiude la serata la formazione del Rev Osagyefo Uhuro Sekou, un quintetto con tastiere e una corista, Sharlisa Brooks. Sekou è molte cose, predicatore battista, attivista per i diritti civili, scrittore, e ultimamente cantante, dopo aver pubblicato lo scorso anno “In Times Like These”, inciso coi fratelli Dickinson e Charles Hodges presso il loro studio Zebra Ranch. La sua musica ingloba tatti aspetti della sua personalità, in primo piano c’è l’aspetto sociale e politico. Fin dall’inizio scoppiettante con “Resist” e il suo reiterato “we want freedom and we want it now”, la sua musica ha elementi gospel, rock, soul, funk e persino reggae, scalda la platea e infatti alla fine del pezzo Sekou, prima abbandona il vestito buono e la cravatta e resta in canotta bianca. Salta su e giù dal palco, attacca sermoni sul razzismo e sulla violenza della società americana, prima di un pezzo, canta con trasporto “In Time Like These” e “We Believe”, cerca costantemente la risposta del pubblico. Nel finale intona “Amazing Grace” oltre ad un bel duetto con la Brooks su “Loving You Is Killing Me”. Un personaggio e un concerto che difficilmente possono lasciare indifferenti.
Dopo ben quindici anni ritorna al festival l’armonicista e cantante RJ Mischo, anche questa volta al suo fianco c’è il chitarrista francese Frank Goldwasser, da anni residente sulla West Coast, schierato assieme all’altrettanto bravo Jeremy Johnson. Suono nell’insieme piuttosto coeso, con Mischo a condurre senza mai strafare all’armonica, anzi dosando a dovere le parti soliste. Piuttosto complementari i chitarristi, Goldwasser ha un tocco personale e Johnson non sfigura affatto, soprattutto nei pezzi d’impostazione tradizionale. Tra le cover ricordiamo “Off The Wall” e “That’s All I Need”.
Giù presente lo scorso anno con al servizio di Ramos e del duo Ledbetter & Welch, quest’anno il tastierista Anthony Geraci è il capitano di un ensemble allargato, i Boston Blues Allstars, con alcuni veterani di lungo corso. La sezione ritmica è formata da Per Hanson e Michael Ward, Troy Gonyea alla chitarra, Greg Piccolo al sax, mentre al canto si alternano, oltre a Geraci, Brian Templeton e Michelle Willson, cantante che qualcuno ricorderà titolare di quattro Cd su Rounder tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del millennio. Portano in scena il recente “Why Did You Have To Go”, dove il numero di amici venuti a collaborare con Geraci è ancora maggiore. Le capacità dei musicisti sono comunque indiscusse, tanto della sezione ritmica, quanto di Geraci. Niente male anche la Willson su “Two Steps Away From The Blues” o “What about Me” con Templeton.
Anche Janiva Magness mancava dal palco del Casino dal 2007, gli anni trascorsi non hanno scalfito la voce e nemmeno il fisico, si direbbe. Qualche modifica nel gruppo, piuttosto stringato, col chitarrista Zachary Ross e la sezione ritmica imperniata su Steven Clay e Gary Davenport. A partire da “Hammer”, Janiva dipana il suo canto su storie di sconfitte e risalite, amori finiti ed altri che portano di nuovo il sorriso, dopotutto l’ultimo lavoro, uscito l’estate scorsa, si intitola “Love Is An Army”. Ed è comprensibilmente ad esso che fa riferimento, per le scelte di repertorio, estraendo ad esempio “Back To Blue”, o la ballata “What Could I Do”, sul disco un duo con Delbert McClinton. La Magness si distingue per presenza e capacità di attingere alle proprie emozioni attraverso il canto.
Infine il quarto gruppo della serata, Barrence Whitfield & Savages, per un concerto ad alto contenuto ritmico, con Whitfield a imbastire trame rockin’soul, voce spigliata e suoni ruvidi sono alla base della loro ricetta, dispiegata in diversi dischi, l’ultimo dei quali, “Soul Flowers Of Titan”, risale alla primavera di quest’anno. “Slowly Losing My Mind” e “Tingling” provengono proprio da qui, così come “Let’s Go To Mars, col sax di Tom Quartulli che si ritaglia sovente un ruolo di rilievo. Non allungano i brani ma preferiscono, come su disco, ma la loro performance è energica e riesce a tener vivo il pubblico nonostante l’ora tarda.
Nel frattempo al piano superiore sono i ginevrini Three Hours Past Midnight a tenere il palco, per un concerto legato alla tradizione di certo blues texano, sulla sei corde di Laurent Gilleron e la voce di Juliana Tarris. Affiancati anche da diversi ospiti come Egidio “Juke” Ingala, Renato Cazzaniga, cantante dei Bluescerne, e addirittura Anthony Geraci, infiammano la platea di casa con una buona dose di allegria e divertimento, portando il pubblico del Casinò a scatenarsi e a ballare fino a tarda notte!
Rockin’ Johnny Burgin, che già la sera prima aveva dato saggio della sua bravura, ricordiamo almeno “Give Me An Hour In Your Garden”, apre la serata di sabato diciassette, accompagnato da Aki Kumar all’armonica, Christian Dozzler al piano e fisarmonica, oltre ad una impeccabile sezione ritmica composta da Chris Matheos e Steven Dogherty. Chicago blues come va suonato, un suono della chitarra di gran gusto, fatto di una tessitura continua e mai ripetitiva. “Grim Reaper” o la rilettura di “Homework” sono di buona fattura, la voce è usata senza forzature, sebbene non sia molto piena. Kumar, buon armonicista canta un paio di pezzi e Dozzler uno, in cui guida il gruppo con la fisarmonica. Un bel set.
Poi ecco Johnny Tucker, per tanti anni batterista con Phillip Walker, titolare a inizio anno di un bel disco di blues tradizionale, “Seven Day Blues” in veste di cantante. Lo affianca la formazione di Anthony Geraci, musicisti navigati in grado di assecondare ogni piega che Tucker imprime alla musica. In più c’è come ospite il chitarrista californiano Kid Ramos Le canzoni sono tratte in maggior parte dall’album, “Come On Home With Me” o “Talking About You Baby”, ma Tucker, come ci raccontava, ha la tendenza ad improvvisare dei testi e quindi di rado un pezzo ha una struttura fissa. L’ensemble in ogni caso funziona e il divertimento gioioso che Tucker comunica si trasmette alla sala senza alcuna mediazione. Applausi meritati per chi, dopo anni da sidemen, si gusta finalmente il centro del palco.

Foto di Philippe Prétet
Molto buono anche il ritorno di Curtis Salgado, ancora con Hager e stavolta con il resto della band, basso, batteria e tastiere. L’artista dell’Oregon, di ritorno al festival dopo qualche anno, è in forma, voce e repertorio sono personali e la sua combinazione di blues, soul e rhythm and blues ha una consistenza vissuta, dati gli oltre quarant’anni di carriera. La set list è ricavata dai suoi tanti dischi, in particolar modo dagli ultimi su Alligator, come il tempo medio “Walk a Mile In My Blues”, la cadenzata “I Know A Good Thing” e la scorrevole “Low Down Dirty Shame”. Tra le cover una “Last Night” compatta e una “Blues Get Off My Shoulder” (Bobby Parker) del tutto convincente, da confrontare ad esempio con quella eseguita dal su ex partner musicale Robert Cray. Un concerto convincente e senza cali di tensione.
Infine, come da tradizione lo zydeco, quest’anno rappresentato da Geno Delafose e dal suo quintetto. Una buona formazione che tra la cover di “Tennessee Whiskey”, cantata dal bassista Popp Esprite e “Swamp’n’roll” o “Hey Geno”, porta a conclusione il festival nella sala principale, non prima di aver invitato sul palco altri due fisarmonicisti qui presenti, Christian Dozzler e il norvegese JT Lauritsen.
Ben figurano anche gli olandesi The Ragtime Rumours, vincitori dell’ultimo European Blues Challenge. Dopo essersi esibiti quasi ovunque in giro per l’Europa e perfino al Santa Maria Blues Festival nelle Azzorre, approdano a Lucerna con la loro carica di giovane età (se si esclude il batterista Sjaak Korsten) e classe, unita alla simpatia. Esibizione quasi interamente composta di originali come “Stop That Train”, “Faker”, “Everywhere I go”, “Ain’t Nobody” o “Love And Lust”, presentano uno show variegato e accattivante, ricevendo dalla platea applausi entusiasti oltre a danze sfrenate tipiche del Casinò, mentre Niki Schuren passa dal contrabbasso al Sax e al flauto traverso con disinvoltura, Thimo Gijezen si dimostra un mago della chitarra e del pianoforte (e persino del contrabbasso), e a Tom Janssen, cantante e leader della band, anche se i nostri quattro sembrano più vivere in comunità, tocca l’arduo compito di mantenere il timone. Il loro blues con forti venature jazz e ragtime è stato immortalato nel nuovo CD “Rag ‘N Roll” uscito ad ottobre per la Ruf Records.
Anche per quest’anno il Lucerne Blues Festival consolida la propria vocazione e richiama un numero costante di appassionati chissà che la prossima edizione, quella del venticinquennale, non riservi qualche sorpresa.
Matteo Bossi

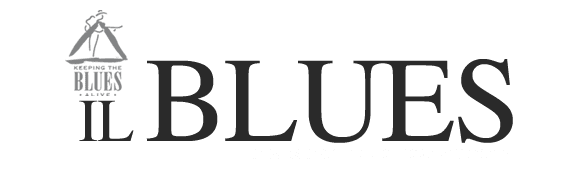


















Comments are closed