Forse non c’è un sinonimo per rock’n’roll a meno di non voler utilizzare… Chuck Berry. Come in fondo già sosteneva, a suo tempo, John Lennon. E’ persino semplicistico qui ricordare quanto abbia prodotto nella sua decade prodigiosa, tra il 1955 e il 1965, era musica per il corpo il suo rock’n’roll, costruito sulla sintesi di elementi country, rhythm & blues e blues, non ha mai celato la sua ammirazione per Carl Hogan, Muddy Waters, Louis Jordan o T-Bone Walker. La musica era vissuta anche sul palcoscenico in modo particolare, incendiario e contagioso. Chuck ci sapeva fare con le parole, le sue canzoni sono tuttora costruzioni perfette, un incastro di ritmo e immagini vivide, innocenza e double entendre, plasmando il linguaggio di espressioni divenute peculiari, tanto è vero che qualche anno fa Bob Dylan (in gioventù a sua volta aspirante rock’n’roller) lo definì “lo Shakespeare del rock’n’roll”. Popolarissimo anche tra i giovani bianchi, tutti quelli che all’inizio dei Sessanta hanno fondato un gruppo, fossero essi inglesi o americani, gli devono più di qualcosa. Quasi un paradosso che l’unico suo pezzo a finire al numero uno delle classifiche sia stato, nel 1972, “My Ding A Ling” e che da allora, in pratica, abbia portato in giro per il mondo il proprio mito e le proprie bizzarrie, suonando con band locali i suoi classici immortali. Sono pezzi talmente inoculati nella coscienza collettiva globale, pensiamo all’uso che ne ha fatto il cinema o la pubblicità, che sembra lunare pensare che non siano sempre stati qui, ma appunto frutto del talento del signor Charles Edward Anderson Berry, da St. Louis, Missouri. La sua musica dal 1977 viaggia nello spazio sul Voyager insieme ad altre testimonianze dell’arte musicale dell’umanità. E la storia non è ancora finita dato che, qualche mese fa, Berry aveva annunciato la pubblicazione, nel giugno prossimo, di un album di inediti intitolato “Chuck”.
Matteo Bossi

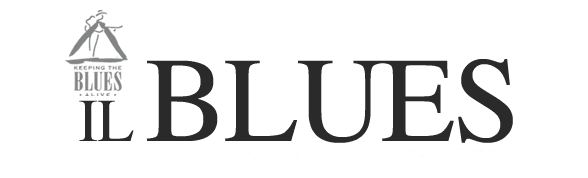










Comments are closed