Arriviamo a Glasgow verso le sei di pomeriggio e fa freddo, molto freddo. Tira un vento gelido che porta piogge intermittenti e spazza le strade. Solo il tempo per il check-in in hotel, per una doccia veloce e siamo pronti per lanciarci nel Celtic Connections, uno dei principali festival musicali nord europei, quest’anno giunto alla ventesima edizione e che si è chiuso il 3 febbraio scorso. Duemila artisti da tutto il mondo, venti location differenti, quattro/cinque main events quotidiani, decine di eventi privati, centinaia di concertini agli angoli delle strade, innumerevoli le jam session improvvisate negli hotel dove risiedono gli artisti, sono i numeri di questa grande kermesse lunga quasi tre settimane. Intorno a me band che sfrecciano in ogni direzione cariche di ogni sorta di strumenti, ragazzini che discutono di un violino o di come suonare al meglio una cornamusa, musicisti impegnati in shooting fotografici (di solito col sottoscritto), manager di mezzo mondo che si incontrano per presentare gruppi e per organizzare tournée. Ovunque negozietti di dischi di seconda mano in cui tuffarsi (io stesso ho trovato un vinile di “The Natch’l Blues” del 1968 autografato da Taj Mahal). Probabilmente vi starete chiedendo cosa c’entri il blues con un festival di musica celtica. La domanda è vera in parte: se da un lato il substrato del Celtic Connections risiede nella cultura tradizionale, dall’altro è veramente una festa della musica globale che spazia dal Folk, all’Indie, dal Jazz al Rock, dalla Fusion al Blues… e che blues. Per iniziare incontriamo Eric Bibb alla festa degli artisti al termine dei BBC Radio2 Folk Awards in cui si è esibito, tra gli altri, Roy Harper (premio alla carriera) il genio che seppe influenzare Led Zeppelin, Kate Bush e Dave Gilmour dei Pink Floyd. Eric confessa di essere rimasto estremamente colpito dalla levatura assoluta dei musicisti che si sono susseguiti sul palco, e profondamente emozionato fino alle lacrime dai brani suonati da Aly Bain (anch’egli premio alla carriera) violinista finissimo e sensibilissimo interprete della tradizione celtica. Ritroviamo Eric il giorno dopo per un breve pranzo in cui ci parla dei suoi ultimi progetti musicali e dei suoi prossimi concerti in Italia. Ci lasciamo dopo mezzora perché deve correre alle prove del concerto serale che lo vedrà protagonista in solo in apertura della rivelazione del 2012: la Heritage Blues Orchestra. Quasi sconosciuta in Italia la band ha pubblicato da poco il suo album d’esordio “And Still I Rise” (Raisin’ Music, 2012) e l’effetto nel panorama del blues americano è stato quello di una bomba nucleare: se il grande Henry Saint Clair Fredericks (si proprio il Maestro Taj Mahal del vinile vintage che ho acquistato) si è subito scomodato a dire che «La Heritage Blues Orchestra è una delle nuove ed eccitanti facce del blues! Elegante, favolosa e rigenerante» paiono dovute e scontate la nomination ai Grammy Award nella categoria “Best Blues Album 2012” e quelle più recenti nelle categorie “Best Album” e “Best Traditional Blues Album” al Blues Music Awards 2013. Già ascoltando l’album, ma ancor più assistendo all’intensa performance live comprendo il perché della doppia nomination di quest’anno: il loro blues è unico perché riesce a essere in modo sconvolgente antico e assolutamente contemporaneo. Ma andiamo con ordine. Dopo il cambio palco, all’improvviso e senza nessun annuncio, sale sulla scena la band. Sia il pubblico nella sala stracolma sia gli artisti sono tutti un po’ spiazzati, l’applauso parte dopo qualche secondo. Quasi intimoriti prendono posto i frontliner Bill Sims Jr. (chitarra elettrica e acustica), sua figlia Chaney (voce) e Junior Mack (chitarra e dobro), gli stessi che compaiono sulla copertina dell’album, e accanto, immobile, Vincent Bucher all’armonica. Dietro di loro si posizionano i fiati Bruno Wilhelm (anche lui francese al sax), Kenny Rampton e Steve Wiseman (trombe), e Clark Gayton (basso tuba, trombone e bombardino) e il batterista Kenny “Beedy Eyes” Smith. Sono a non più di due metri dagli artisti. Chaney, sorride alla platea, chiude gli occhi e batte le mani: inizia “Clarksdale Moan” e subito non siamo più in Scozia ma nel Delta del Mississipi. Chitarra, voce, una ritmica minimale e incalzante. Come sprazzi di colore nel nero gli arrangiamenti di Bruno Wilhelm ci parlano di una sezione fiati che pennella note chiaroscurali da marching band di New Orleans, esprimendo con eleganza la scuola jazzistica europea. A legare il tutto il filo rosso dell’armonica di Bucher.
È il momento di “Catfish Blues” col suo approccio muscolare da blues bianco della zona dei grandi laghi. Qui è l’armonica frenetica, ossessiva, quasi folle a farla da padrona sia nel suo essere basso continuo per la voce graffiata sia per i suoi fraseggi distorti. E ancora una volta i fiati che giocano a fare la big band. Col terzo brano in scaletta “C-Line Woman” l’atmosfera cambia: su una ritmica tribale sostenuta dal basso tuba, la Sims reclina indietro la testa battendo le mani e parte una preghiera laica tra il traditional e il work song a canto alternato siamo proiettati indietro di due secoli e mezzo. Con le ultime note del terzo brano finisco il mio tempo a disposizione per fotografare. Ripongo l’attrezzatura mi siedo per terra accanto al palco, chiudo gli occhi e mi lascio trasportare. Il resto del concerto è un viaggio a cavallo tra atmosfere Delta Blues, con chitarre slide e arrangiamenti che sfiorano il funk, il country e il jazz. Ancora ombre, luci, pennellate di colore, sofferenza primordiale, hoodoo, eleganza. La ricetta della band è chiara: contaminazione tra artisti francesi ed americani e tra cultura musicale colta e tradizionale, per un sapiente ma geniale lavoro di sartoria tra le tre componenti dell’espressività umana: pancia, cuore e intelletto. Gli inglesi parlano del folk come di una “Living Tradition”, concetto che è stato ribadito più volte durante le serate del Celtic Connections e la Heritage Blues Orchestra è la prova che il blues ha la grande forza di rigenerarsi rimanendo sempre se stesso.
Mario Rota

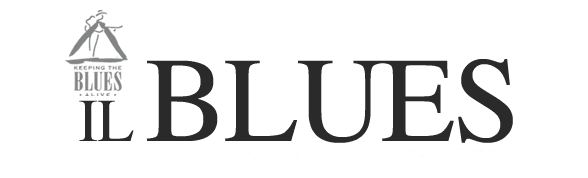









Comments are closed