I mancini, si sa, sono dotati sovente nell’arte, nello sport o nella musica di un talento spiccato, che sfiora la genialità, accompagnato ad una certa incostanza. Rifiutano la banalità e sono in genere capaci di essere ispiratissimi e regalare capolavori o colpi memorabili, accanto a momenti di appannamento in cui sembrano estraniarsi. E’una considerazione che crediamo calzante per la carriera di Otis Rush, artista che ci ha lasciato il 29 settembre scorso, dopo che da anni le conseguenze di un ictus ne avevano compromesso purtroppo la possibilità di suonare. I suoi inizi, come noto, sono straordinari, Rush ha appena ventidue anni quando, grazie a Willie Dixon, esordisce sulla neonata Cobra di Eli Toscano con “I Can’t Quit You Baby”. L’avventura Cobra sarà di breve durata, ma avrà il tempo di incidere una serie di pezzi destinati a conquistare lo status di classico, segnando l’affermarsi di una diversa generazione di musicisti, quelli nati nel corso degli anni Trenta. Seguono infatti cose come “My Love Will Never Die”, “Groaning The Blues”, “Double Trouble”, “All Your Love”. E poi “So Many Roads, So Many Trains”, uscita per Chess e “Homework” per Duke. Tutti questi titoli li troveremo nel repertorio di Mayall, Clapton, Led Zeppelin, J.Geils Band, Fleetwood Mac, Stevie Ray Vaughan, Rolling Stones…Ma gli anni Sessanta, nonostante tutto, sono piuttosto avari di soddisfazioni e bisogna attendare la fine della decade per un vero e proprio Lp a suo nome, “Mourning In The Morning”, prodotto da due suoi ammiratori, Bloomfield e Gravenites, inciso a Muscle Shoals con tanto di fiati e, in alcuni brani, Duane Allman. Di nuovo Gravenites gli produce nel 1971 il buon “Right Place, Wrong Time”, che però non esce se non cinque anni dopo. Scottato da queste esperienze, Rush si fa imprevedibile e l’attività in studio si dirada parecchio.
Dal vivo invece prosegue e numerose sono le testimonianze su disco delle sue prestazioni, dal Giappone (Delmark), all’Europa (Nancy, Montreux) agli Stati Uniti (San Francisco, in due differenti occasioni), con vari gradi di riuscita, a metà strada tra routine e convinzione. Ma ci sono serate di grazia in cui ritrova la verve migliore e, come certi campioni, sembra giocare in una categoria a sé stante; è il caso del live al Wise Fools Pub di Chicago pubblicato solo nel 2004 da Delmark col titolo “All Your Love I Miss Loving”. Torna in studio negli anni Novanta per un paio di solidi dischi, il secondo, “Any Place I’m Going” gli vale persino un Grammy, anche se non gli arride la medesima fortuna e il medesimo riconoscimento dal mondo del rock che ottiene a partire da quel periodo, il suo quasi coetaneo Buddy Guy. Forse sottostimato, ma benvoluto e idolatrato da colleghi e discepoli, più o meno diretti, basti ricordare le parole di Carl Weathersby nell’intervista pubblicata sul n.144 e il tributo che gli venne dedicato in occasione del Chicago Blues Festival del 2016. In una prospettiva storica la figura di Rush rappresenta un tassello imprescindibile e senza questo magnifico alfiere del West Side Blues, non ci restano che Buddy Guy e Jimmy Johnson, come testimoni ancora battaglieri di una fase irripetibile.
Matteo Bossi

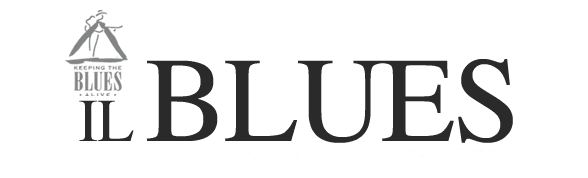











Comments are closed