Sembra ridicolo parlare di un ritorno di Corey Harris, che non se n’è mai andato. Siamo noi piuttosto, ad averlo perso di vista, anche se non l’abbiamo mai dimenticato, come portavoce di una nuova generazione blues a metà degli anni novanta. Quegli anni che ce lo ritrovavano, con Alvin “Youngblood” Hart o Guy Davis e così pure Keb’Mo’, quali afroamericani a riprendersi in mano il suono delle radici, attestazione di un’identità attraverso un linguaggio in evoluzione, e per dirla alla Leroy Jones: non un manufatto che piace, riprodotto per vendere, ma un idioma che si evolve, e si trasforma all’attualità che lo compenetra. Ma se è un discorso che oggi non possiamo fare con certezza per gli altri che abbiamo citato, per Harris è stato così che lo abbiamo visto fin dagli inizi, ad allargare l’orizzonte oltre i confini degli USA, per giungere a un senso lato dell’Afro-America, tra Caraibi e America latina, fintanto che giunse alla terra madre Africa con “Mississippi To Mali” e lo incontrammo proprio vent’anni orsono in quell’odissea “scorsesiana” del Blues, testimone di una “new wave” afroamericana che, a ritroso, ne ha evidenziato le connessioni con la black-music stessa. Sì che lo accosterei oggi piuttosto ad Eric Bibb, in un lavoro progressivo sulla musica come affondo nella nostra realtà, a decodificarne un punto di vista di critica sociale che ne ha ben donde, quasi a poter accostare “Insurrection Blues” di quello a “Dear America” di questi (entrambi 2021, non a caso e quasi si prefigurassero questo nostro presente).
E dopo Alligator, Rounder o Telarc, è quando le ristrettezze pandemiche lo hanno costretto in Italia che lo ritroviamo con l’etichetta Bloos di casa nostra e l’album di cui parliamo è ascoltabile già da un po’, che tra qualche mese ha già un anno e quantunque poco noto, s’è potuto annoverare tra i bei dischi dell’ultimo 2024. La sua dedica stavolta, va alla città che l’ospitò quando cominciava a fare musica, per le strade della Crescent City e l’ “Uomo dei polli” del titolo, altri non è che un fantomatico voodoo – man del folklore afro – caraibico della Big Easy, altro nomignolo in voga per la città di New Orleans appunto, che non solo ad un patois linguistico ma anche musicale, multietnico, religioso e infine culturale deve le sue molteplici facce. E non fosse che siamo in prossimità di un altro Mardi Gras a riportare in auge questi suoni; ma della Corey Harris band, perché il nostro “blues – preacher” non è solo e assieme a fidi compari come Teresa Ti Jones al basso, Paul Dudley alla batteria, Gordon “saxman” Jones al sassofono e persino Cheick Diabate su ‘ngoni, propone una dozzina di tracce che attingono alla sua incommensurabile loquacità musicale. Come la canzone “portante” dell’album, che è anche il solare pezzo in apertura, un potente errebì intorno alla figura dello stregone che da il titolo al disco e alle strade di N.O.L.A.; e se “Ain’t Gone Back No More” ne segue l’imprinting sassofonistico a connotarne i tratti più soul, sono i blues solitari come “Money Hungry” o “Since You Gone” poco più avanti, a riscoprire l’Harris degli albori, più Delta & downhome, che non tralascia la verve politica nel ritmico blues urbano di “Jim Crow Joe” (per l’ex – inquilino della Casa Bianca) o il richiamo dell’Africa, un’altra volta all’icona maliana di Ali Farka Touré, con “Jahtigui” per un altro faro di Harris e della black-culture. Solo alcuni estratti, da un bel disco un po’ troppo taciuto, di cui ci piace ricordare anche l’ottima soul-ballad “Four Wings”, come la track in chiusura, “Great Change”: a cappella e profondamente black, come di un griot lontano, tra i campi, a primavera.
Matteo Fratti
Info: sito Bloos

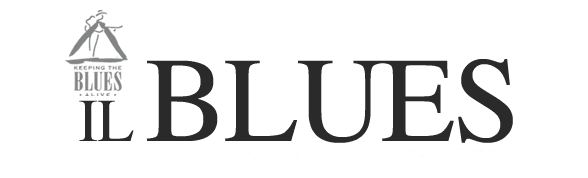







Comments are closed